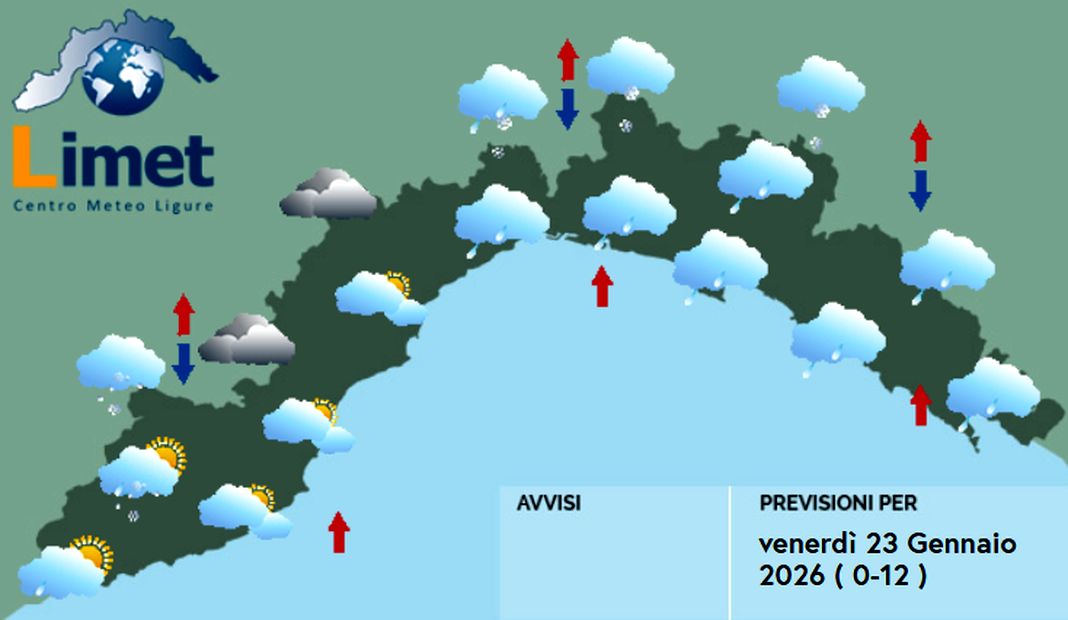In pochi conoscono la storia del marinaio genovese Giovanni Battista che ha vissuto per ben otto anni su un’isola deserta dei Caraibi dopo il naufragio della sua nave.
La storia riporta che il disastro avvenne nel 1528 quando il marinaio genovese, imbarcato su una nave spagnola a Santo Domingo, fece naufragio a causa di una tempesta.
A scoprire la vicenda lo storico argentino Enrique de Gandia che, nel 1932, riportò alla luce un documento tratto dalla “Historia General y Natural de las Indias” redatta nel XVI secolo da Gonzalo Fernandez de Oviedo. Fra le moltissime cose citate, il documento racconta del naufragio occorso nel 1528 al “maestre genoves Juan Bautista” su un isolotto del Banco della Serrana, un arcipelago di piccole isole sabbiose al largo del Venezuela.
La straordinarietà della notizia sta nel fatto che il genovese Giovanni Battista, rimase su un’isola di sabbiosa per otto anni, per poi essere tratto in salvo. Egli stesso, una volta tornato in Spagna, dedicò le sue memorie all’imperatore Carlo V.
Dopo la perdita delle colonie genovesi in Asia Minore e nel Mediterraneo a causa degli Ottomani e dopo che i re Cattolici avevano liberato la Spagna dai mori, molti liguri andarono a vivere in quella nazione. Con la loro proverbiale intraprendenza, in pochi anni riuscirono a creare una fitta rete di attività commerciali, con le quali finanziarono, anche se in parte, il viaggio di Cristoforo Colombo.
Dopo la scoperta dell’America, nella speranza di nuove ricchezze, molti liguri s’imbarcarono sulle navi spagnole, sia come naviganti o al seguito dei conquistadores.
Uno fra questi fu il genovese Juan Bautista che, trovandosi a Santo Domingo, s’imbarcò su un veliero come “maestre”, cioè “nostromo”.
L’imbarcazione era diretta all’isola Margarita, di fronte alla costa venezuelana ma alcuni giorni prima di arrivare fu sorpresa da un fortissimo uragano e scaraventata su un isolotto dell’arcipelago della Serrana.
Essendo un buon nuotatore, Giovanni Battista riuscì a raggiungere a nuoto l’isola portando con sé un corno di polvere da sparo e un acciarino, poi tornò verso il relitto e portò in salvo altri sei marinai.
Dopo essersi ripresi dalla terribile avventura, il giorno dopo, si recarono alla nave per vedere se si poteva recuperare qualcosa di utile alla loro sopravvivenza. Ma la marea aveva trasportato via qualsiasi cosa.
Rimaneva loro solo la polvere da sparo e l’acciarino, ma in mancanza di pietra focaia, gli oggetti erano inutilizzabili.
Per due mesi i poveri naufraghi furono costretti a mangiare carne cruda di uccelli e leoni marini e a bere il loro sangue per dissetarsi.
Col passare del tempo e vista la situazione disperata, tre naufraghi decisero di costruirsi una sorta di zattera con dei legni portati a riva e con questa precaria imbarcazione, cercare di raggiungere qualche isola abitata, ma di loro non si seppe più nulla.
Un altro grosso problema per chi era rimasto sull’isola, era la mancanza assoluta di acqua dolce, per cui per dissetarsi essi dovevano mescolare l’acqua salata al sangue dei leoni marini.
A causa di queste sofferenze, un giorno il marinaio Moreno de Malaga fu preso da un attacco di follia e poco tempo dopo morì.
Nella speranza di procurarsi un po’ d’acqua dolce, Giovanni Battista e il compagno rimasto, scavarono delle buche con il guscio di alcune tartarughe ricoprendole poi con delle pelli di leoni marini, ma il poco liquido raccolto dovette essere nuovamente mescolato col sangue dei mammiferi, poiché il loro stomaco non era più abituato all’acqua dolce.
Con l’avvicinarsi della brutta stagione, i due naufraghi capirono che dovevano accendere un fuoco a tutti i costi, per cui Giovanni Battista si costruì una piccola zattera con la quale raggiunse il punto dove la nave era naufragata.
Dopo una serie di tentativi e tuffandosi fra i rottami, egli riuscì a recuperare una selce che servì finalmente ad accendere un fuoco, cucinare quel poco che avevano e riscaldarsi.
Qualche tempo dopo, attratti dal fuoco che vedevano acceso, due naufraghi che vivevano in un’isola vicina già da alcuni anni, riuscirono a raggiungere Giovanni Battista e il suo compagno. I quattro disperati si fecero compagnia per cinque lunghi anni, poi, vedendo che la speranza di essere tratti in salvo si allontanava sempre di più, si costruirono una zattera armata con vele fatte di pelle di leone marino nella speranza di raggiungere la Giamaica, ma una volta preso il largo e vedendo l’imbarcazione poco sicura, Giovanni Battista e un altro ragazzo si fecero riportare a terra.
Anche se rimasti in due, il problema della sopravvivenza giornaliera era sempre più urgente. Nei mesi di aprile e maggio, essi riuscirono a catturare delle tartarughe e nutrirsi con le uova che depositavano nella sabbia, e in certi casi, una volta lavate e seccate al sole si potevano conservare per i mesi in cui c’era poco da mangiare.
Giovanni Battista racconta che tenendo le uova sotto la sabbia per qualche tempo, il loro albume si trasformava in acqua, consentendogli di placare la sete per cinque mesi l’anno.
In seguito, quando le femmine di leone marino venivano sulla spiaggia a partorire i loro piccoli, i due li uccidevano e si nutrivano della loro carne che era meno indigesta di quella degli adulti. Inoltre, servendosi di grosse conchiglie i naufraghi estraevano dai loro stomaci il latte appena succhiato, lo facevano bollire nelle conchiglie stesse e per quanto fosse acido, lo bevevano.
Tempo dopo riuscirono a costruirsi una peschiera, che collegata al mare da un canale, permetteva ogni tanto di catturare qualche pesce.
Con le pelli di leone marino e qualche legno riuscirono a costruirsi delle rudimentali capanne e una sorta di sacco a pelo per non essere morsi dai granchi mentre riposavano.
Narra Giovanni Battista che i due momenti, sentendosi gravemente malato, si procurò dei salassi di sangue per liberarsi dai “cattivi umori” che avevano causato la sua infermità. Una pratica scientificamente destituita di fondamento ed anzi contro-producente, specie in persone dal fisico debilitato.
In ogni caso, i momenti più terribili furono quelli in cui, a causa della loro debolezza, essi venivano presi dalla disperazione e da terribili allucinazioni.
Racconta Giovanni Battista che per un certo periodo i naufraghi avevano deciso di vivere separatamente, ma un giorno, quando inavvertitamente si rincontrarono, si spaventarono a vicenda e fuggirono via spaventati.
Un’altra volta, svegliatosi in piena notte, gli sembrò di vedere una creatura mostruosa che la sua immaginazione scossa e allucinata identificò con il diavolo. Dopo aver svegliato il suo compagno, percorsero tutta I’isola muniti di un crocefisso di legno per allontanare il demonio che da quel momento non riapparve più.
In ogni caso, col passare del tempo e sempre speranzosi di essere salvati, con i pochi sassi trovati sul fondo marino, i due naufraghi costruirono anche alcune torri sulle quali accendevano il fuoco.
Finalmente, il 23 settembre 1536, un veliero che transitava da quelle parti vide il fumo provenire dall’isola e i due naufraghi furono tratti in salvo.
Dopo alcuni giorni sbarcarono all’Avana, dove l’adelantado della città li prese sotto la sua protezione e dopo aver ascoltato le loro peripezie, predispose che fossero accompagnati in Spagna per fare relazione del loro naufragio.
Fonti:
http://www.ebooksread.com/authors-eng/university-of-notre-dame-1983-1988/annali-ditalianistica-volume-10-1992-vin/page-12-annali-ditalianistica-volume-10-1992-vin.shtml
UMBERTO TORRETTA
[email protected]