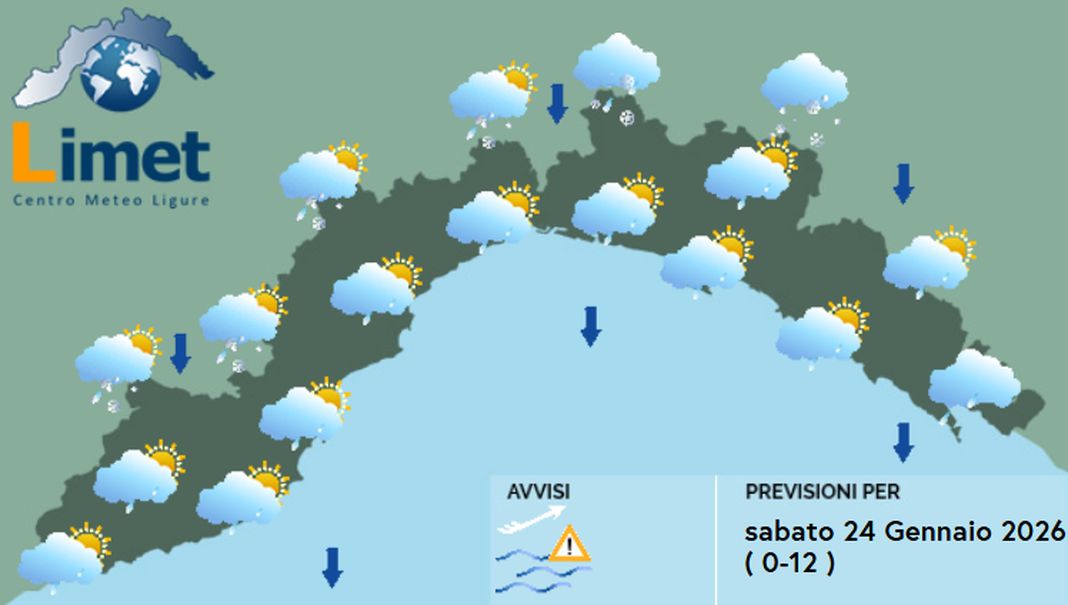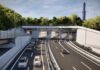Genova – Si conclude al confine con la Svizzera l’indagine avviata dai giudici genovesi sulla decisione di una donna di 60 anni, da tempo affetta da una grave malattia degenerativa, che ha scelto di morire nella civile confederazione elvetica, con la pratica del cosiddetto “suicidio assistito”. I giudici svizzeri hanno infatti opposto il rifiuto, garantito dalle leggi locali, alla richiesta dei colleghi italiani di poter accedere alla documentazione sul caso, custodita nella clinica dove la donna ha posto fine alle sue sofferenze secondo la normativa in vigore da anni nel Paese.
Genova – Si conclude al confine con la Svizzera l’indagine avviata dai giudici genovesi sulla decisione di una donna di 60 anni, da tempo affetta da una grave malattia degenerativa, che ha scelto di morire nella civile confederazione elvetica, con la pratica del cosiddetto “suicidio assistito”. I giudici svizzeri hanno infatti opposto il rifiuto, garantito dalle leggi locali, alla richiesta dei colleghi italiani di poter accedere alla documentazione sul caso, custodita nella clinica dove la donna ha posto fine alle sue sofferenze secondo la normativa in vigore da anni nel Paese.
I giudici italiani non potranno sapere i nomi dei medici e neppure di coloro che potrebbero aver aiutato la donna ad organizzare il viaggio.
I fatti risalgono al 2016 quando la donna, ormai consapevole di non avere alcuna speranza di guarigione e affetta da una malattia che la faceva soffrire senza alcun motivo, ha contattato un’associazione specializzata in Svizzera senza informare i parenti della sua decisione.
L’associazione si è occupata di organizzare ogni dettaglio, compreso il trasporto in ambulanza sino in Svizzera, nella clinica dove è possibile esercitare il diritto di scegliere come porre fine alla propria vita in caso di sofferenze indicibili.
Una norma che è molto diversa da quella appena approvata in Italia che consente di interrompere volontariamente le cure ma lascia che il paziente possa morire di inedia, senza acqua o senza cibo, dopo una sedazione profonda che non interrompe la vita.
In Svizzera è invece possibile scegliere di assumere una miscela di farmaci che fa scivolare il paziente dal sonno alla morte, in pochi minuti. La morte per inedia può invece sopraggiungere dopo giorni e giorni.
Le indagini sul caso proseguiranno sul “versante italiano” per accertare se qualcuno ha aiutato la donna in Italia ma molto probabilmente il fascicolo si chiuderà con un “nulla di fatto”.