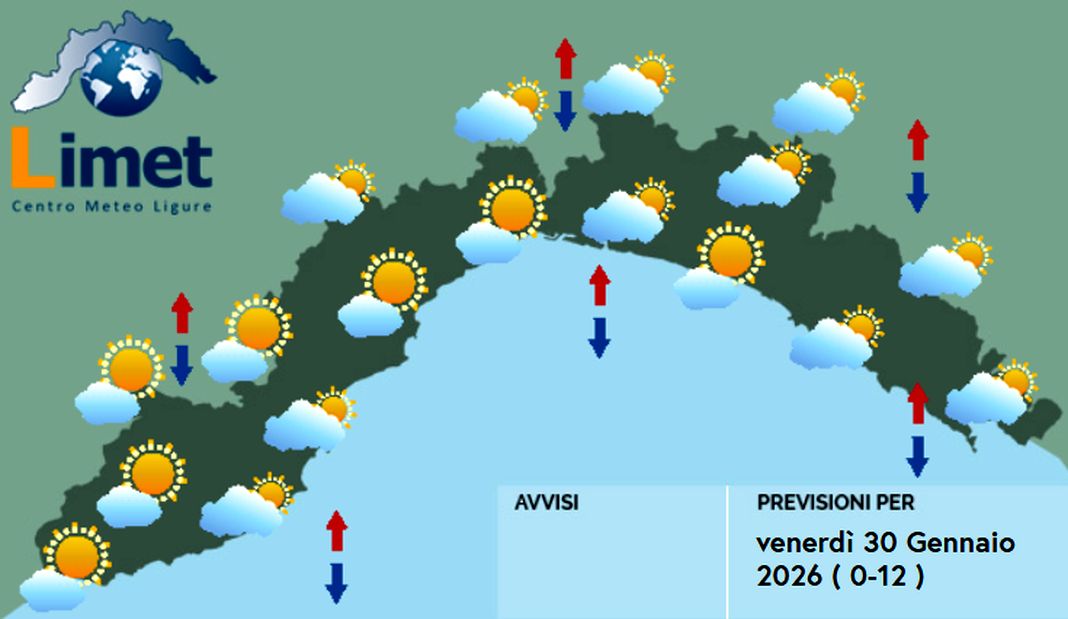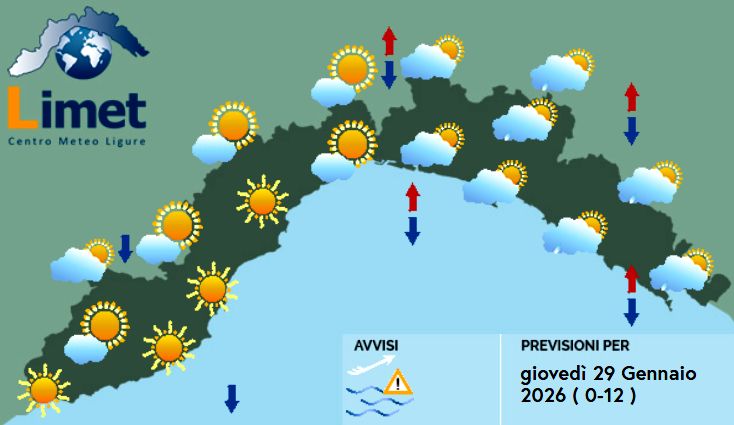Genova – Tra le tante cose che sono state scritte pro e contro il Pesto, ha destato particolare curiosità la notizia secondo la quale l’aumento del consumo della gustosa salsa verde sarebbe all’origine di un’invasione di orsi bruni in alcune cittadine della Russia.
Qualche tempo fa i genovesi – loro malgrado – si sono trovati al centro di un infuocato dibattito mondiale su pinoli e pesto.
Se in Liguria questo genere di discussioni possono diventare anche abbastanza accanite, una simile risonanza internazionale sembrava del tutto insolita, ma ha messo in luce un dato che forse non sospettavamo: il pesto alla genovese è una salsa rinomata ormai a livello globale.
Tutto è cominciato il 19 ottobre 2015, con la pubblicazione da parte del New York Times di un articolo di Jonathan Slaght, biologo americano molto attivo nella lotta per la conservazione degli habitat naturali, che denunciava come la crescente domanda di pinoli da parte del mercato nordamericano, stimolata dalla sempre maggiore popolarità del pesto negli States, aveva spinto gli abitanti di Luchegorsk, un remoto insediamento a nord di Vladivostok al confine tra Russia e Cina, a “saccheggiare” letteralmente le foreste di pini circostanti così da riempire sacchi di preziosi pinoli che mercanti cinesi avrebbero rivenduto illegalmente in America spacciandoli per coreani.
A spaventare tuttavia il biologo non era tanto quest’inedito aspetto piratesco del mercato globale, quanto le conseguenze disastrose del deperimento di un ecosistema così particolare: la scomparsa dei pinoli aveva portato all’abbandono della foresta da parte degli animali di piccole dimensioni, rimasti privi di un’importante fonte di sostentamento; risalendo la catena alimentare, a restare senza cibo erano rimasti i grandi (e rari) orsi bruni dell’Amur, col risultato che gruppi di orsi avevano finito con lo scendere in città in cerca di cibo, a volte aggredendo gli abitanti.
Dato che il pesto è diventato uno dei condimenti più amati a livello mondiale, da un punto di vista giornalistico la storia era particolarmente ghiotta e difatti venne immediatamente ripresa da diverse testate internazionali: L’Independent, due giorni dopo la pubblicazione del pezzo di Slaght sul New York Times, titolò “Pesto: come l’insaziabile domanda di pinoli per fare la salsa è dannosa per l’ambiente” (un po’ come il celeberrimo “Questo è il costo dello zucchero che mangiate in Europa” del Candide di Voltaire).
In Italia ne parlò anche Repubblica in un articolo dove, sulla scorta del NYT, ci si domandava: “Un affronto, quello del biologo americano, alle tradizioni culinarie della Riviera ligure? Una interferenza indebita nel lavoro degli chef? «I libri di cucina e i siti web sono pieni di ricette di pesto senza pinoli», si difende Slaght.
Che, in alternativa alla abolizione completa, ipotizza di sostituire i pinoli con mandorle, noci o pistacchi, oppure di usare i pinoli di provenienza americana”.
Non bisogna essere esperti di comunicazione per notare come una notizia, inizialmente riportata in modo “oggettivo”, stava scivolando su un piano morale: “L’insaziabile domanda”; “Un affronto alle tradizioni“… ci pensò Wired, rivista popolarissima tra gli internauti, a far precipitare la situazione, pubblicando all’indomani del pezzo su Repubblica un articolo il cui titolo sparava a piena pagina “Mangiare il Pesto è roba da matti“, offendendo in un colpo solo qualcosa come 1 milione e 583.236 persone (gli abitanti della Liguria secondo l’Istat).
Dopo qualche giorno di commenti infuocati o indignati, la cosa finì lì, lasciando però l’impressione che il solo che si fosse preoccupato di conoscere qualcosa di più sul pesto fosse proprio il dottor Slaght; un lettore che si fosse imbattuto in questi articoli senza sapere nulla del pesto avrebbe finito per conoscere meglio l’ecosistema di una sperduta valle della Manciuria, finendo per credere che i nostri nonni – che per inciso facevano il pesto con quello che avevano via via a disposizione – fossero i veri responsabili del riscaldamento globale.
Le polemiche sul pesto non erano però finite: nell’ottobre dell’anno scorso, il Guardian pubblicò un articolo assai critico che scatenò in Italia un vero e proprio putiferio, con tanto di interessamento delle istituzioni. A dire la verità, l’articolo conteneva elementi – a mio avviso – perfettamente condivisibili; oggetto di biasimo da parte del giornale non era infatti il pesto in sé, quanto l’uso da parte dei supermercati britannici di mettere in commercio salse eccezionalmente salate: per migliorarne la conservazione a detta dei produttori, più probabilmente per risultare più saporite al palato dei bambini, con effetti però assai poco salutari sul lungo periodo (e, tra l’altro, fidelizzando il cliente verso un sapore che non è quello del pesto, ma somiglia probabilmente più alle patatine fritte).
Grazie alla testata inglese, i liguri scoprirono che nel Regno Unito vengono commercializzate salse dal nome suggestivo come “Napolina Green Pesto with Basil”
Evidentemente, gli sforzi di comunicazione relativi a una salsa che fa parte delle nostre tradizioni e della nostra storia non sono veicolati in modo giusto: al di là delle sterili diatribe tipo “pinoli sì” “pinoli no“, il problema è molto più serio di quanto potrebbe sembrare, dato che un prodotto di eccellenza della nostra cultura sembra esserci sfuggito di mano a livello mondiale.
Forse la nostra è solo un’impressione, essendo ancora “traumatizzati” dall’esserci trovati davanti, durante un volo verso il Medio Oriente, una vaschetta al cui interno una “Green Pesto Basil Cream” ricopriva una manciata di tortellini indifesi, ma si rischia di finire come con i Jeans Blue de Genes, che oggi è un marchio registrato a Copenaghen.